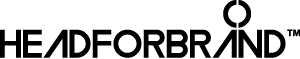Brand name, la colonna portante dell’identità di marca
Degli elementi che compongono un marchio il più fragile da manipolare è senza dubbio il nome. È il primo contatto con l’esterno e dovrebbe inquadrare, o al limite evocare, sin da subito la proposta commerciale trasferendo con decisione l’essenza della marca. Succede, però, che molti potenziali brand nascano svincolati da un’idea di identità e posizionamento, relegando il nome a mero espediente per la riconoscibilità o, nel migliore dei casi, a semplice elemento di distinzione verbale. Evidentemente il nome per una marca è molto di più: conferisce un profilo connotativo, trasmette un messaggio intriso di informazioni, materializza una vision, fa sistema, narrativizza.
Tutto si può modificare nel corso della storia di un brand: un packaging, la comunicazione, anche il «logo» e le persone che la rappresentano istituzionalmente. Invece cambiare il nome di un’azienda o di un prodotto dovrebbe – a meno che sussistano ragioni di opportunità non preventivabili a monte – rappresentare l’ultima spiaggia. Quindi meglio porre attenzione prima piuttosto che rimediare in qualche modo dopo o, peggio, non comprendere che il nome della nostra marca ci sta penalizzando. È quello che succede a centinaia di aziende, mediamente poco inclini a investire energie sui codici verbali e alle prese con metodi di costruzione non sempre ortodossi. Concentrando lo sguardo sulle imprese italiane di dimensioni più contenute, ho notato spesso che vengono commessi degli errori, frutto di scarsa dimestichezza con l’argomento e disinformazione, che porta ottimi imprenditori ad «approvare» la prima soluzione ritenuta – su basi fallaci – praticabile. Nel settore business-to-business, ma non solo, c’è una parte di amministratori che delega l’onere della scelta del nome al proprio consulente commercialista, perché «è lui che si occupa delle società». O anche chi bandisce una sorta di concorso tra i dipendenti e poi va al ballottaggio all’interno del proprio nucleo famigliare.
Decidere il nome di marca non è necessariamente un’attività che deve assorbire energie smisurate o gravare sul conto economico: è possibile ottenere dei buoni risultati anche lavorando in autonomia, ma bisogna attenersi a delle regole precise. Una delle prime cose da tenere a mente è che l’attività di naming non è un esercizio di creatività ma un processo interdisciplinare che abbraccia a doppio filo marketing, comunicazione, linguistica, semiotica e diritto (proprietà industriale). Esistono delle caratteristiche che un nome di marca dovrebbe sempre possedere, tra queste le principali sono: originale, orecchiabile, evocativo, memorabile, tutelabile legalmente, semplice, mutabile (aperto al cambiamento) e coerente. In certi casi è tuttavia possibile puntare maggiormente, ad esempio, sull’originalità a danno della semplicità: sono valutazioni da farsi in corso d’opera, che variano r

Qualche tempo fa avremmo potuto distinguere i brand name dai company name ma oggi queste distinzioni sono sempre più una sfumatura, come sembrano affermare implicitamente colossi come P&G e Unilever che, contrariamente al passato, hanno cominciato a firmare i rispettivi annunci pubblicitari. P&G, addirittura, è passato dal ruolo di regista occulto a quello di attore protagonista: l’emozionante ed empatico commercial «Thank You, Mom» ha fatto venire la pelle d’oca a miliardi di spettatori sintonizzati davanti alla TV per le Olimpiadi di Londra 2012.
Tipologie di brand name
I nomi di marca possono essere raggruppati in tre tipologie principali: denotativi (o descrittivi), connotativi (o evocativi), patronimici (o nomi propri).
I nomi denotativi descrivono il prodotto o servizio, senza lasciare spazio a particolari interpretazioni. General Electric, Trenitalia, Divani&Divani, Parmalat, Riso Gallo, Borotalco Roberts sono alcuni esempi. Il vantaggio di questi nomi è quello di godere di memorabilità e di essere riconosciuti come familiari nei propri mercati. Di contro, un nome descrittivo è meno carismatico e mal si presta a costruire/solleticare l’universo della marca. Inoltre potrebbe, in alcuni casi, diventare una vera e propria zavorra in prospettiva di medio periodo, come nel caso di Calzedonia, rimasta imbrigliata in un abito che si era tagliata su misura ma che è risultato oltremodo scomodo quando ha deciso di fare brand extension (ha dovuto lanciare un altro brand, Intimissimi, con ottimi risultati peraltro). A volte è possibile raccontare esplicitamente l’offerta mantenendo valide qualità distintive: è il caso della compagnia aerea spagnola Vueling, che ha costruito in maniera insolita il suo nome unendo parole di differente origine linguistica («vuelo» + « ing»).
I nomi connotativi evocano quel mondo di associazioni extra-funzionali e sono i più adatti per costruire un significato personale. È come se coinvolgessimo le persone in un gioco, dove forniamo loro una parola che può essere intesa in diversi significati e arricchita da un punto di vista soggettivo. Apple, Nike, Virgin, Google, Amazon, Starbucks, Sony, Jaguar, Victoria’s Secret. Se sono delle grandi marche lo devono anche all’originalità dei loro naming; se sono cool è perché tutti noi gli riconosciamo – oltre a un prodotto valido – delle peculiarità simboliche. Va anche detto che non bisogna neppure farsi prendere la mano lanciandosi alla ricerca di stramberie o improbabili exploit lessicali. C’è il rischio che il gioco diventi un anagramma respingente.

A proposito di nomi evocativi, poco tempo fa ho letto su Originals (Adam Grant, 2016 I trad. it. Essere originali, Hoepli, 2016) che l’insuccesso del movimento Occupy Wall Street sia in parte ascrivibile al nome che «implicava di […] andare a occupare qualcosa». Sono solo in parte d’accordo, ma questa considerazione ci fa capire quanti valori trasmetta oggi un nome – anche in contesti generalisti – e in che misura venga ritenuto artefice di un successo.
I nomi patronimici sono invece quelli che derivano da una persona, solitamente il fondatore dell’azienda. Sono forse quelli più diffusi, con delle punte altissime nei settori legati al Made in Italy (specialmente nell’alta moda e nel lusso), senza dubbio una tendenza che ha fatto storia ma che oggi è meno diffusa. Ferrero, Barilla, Lavazza, Ferrari, Benetton, Dolce&Gabbana, Armani, Cucinelli, Versace, Feltrinelli, De Cecco, Rana, Campari, Recordati sono alcuni dei centinaia che tutti i giorni incrociamo nelle vetrine, in TV o sugli scaffali dei supermercati. Anche all’estero, grandi brand hanno origine dal cognome del proprio leader: ricordiamo Ford, Disney, McDonald’s, Nestlé, Hewlett-Packard, Kellogg’s, Hilton. Denominare un’impresa assegnandole il proprio nome esercita sempre un certo fascino negli imprenditori perché dà la possibilità di tramandare la storia di famiglia ed è la soluzione più semplice in quanto permette di saltare a piè pari i passaggi più complessi di naming. Questo ragionamento è comprensibile ma non sempre lungimirante. Esistono dei casi, la maggior parte, dove il cognome dell’imprenditore è off limits, o più semplicemente non adatto a qualificare un’attività professionale per le stesse ragioni accennate in precedenza: non evoca, non suona bene, non comunica incisivamente. Il consiglio è dunque quello di essere il più possibile oggettivi e, se non si riconosce una forma buona nel proprio cognome, abbandonare l’idea di utilizzarlo.
Sigla, acronimo, onomatopee
Tra le strade più battute ci sono le sigle e gli acronimi, costruite fondendo più nomi o una ragione sociale particolarmente corposa. Si utilizzano in quasi tutti i mercati, a volte si rivelano indispensabili, come ci ricorda il corriere espresso (ex) Bartolini che, per allinearsi agli altri player (TNT, SDA, UPS, DHL) e favorire l’internalizzazione del marchio, si è trasformata in BRT. LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A.), ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), FCA (Fiat Chrysler Automobiles), BBC (British Broadcasting Corporation), OVS (Organizzazione Vendite Speciali) sono altri esempi di sigle e acronimi. Su questa strada ricordiamo PPR (Pinault-Printemps-Redoute) che nel 2013 ha fatto renaming con Kering: «ker» («casa», in bretone) + l’assonanza con la parola care/caring inglese (cura, attenzione).
Le parole che imitano un suono – le onomatopee – sono nomi capaci di indirizzare a una precisa caratteristica della marca; che sia un particolare del packaging (Tic-Tac, il tipico suono dell’astuccio richiudibile), della musicalità del prodotto (Strep, le strisce depilatorie che strappano) o simbolicamente al mondo dei fumetti (Rai Gulp, il canale dedicato ai bambini).

Bizzarro il caso Yahoo!*, nato come acronimo non proprio ortodosso (Yet Another Hierarchical Officious Oracle), è diventato in poco tempo il più potente dei nomi onomatopeici evocando i vari «yuu» o «yuuu» – suggellati dal punto esclamativo – a descrivere «l’urlo di esultanza» e l’allegria che scaturiscono dall’utilizzo della comunicazione Internet.
Possiamo concludere questo breve viaggio nel complesso mondo del naming con alcune macro-considerazioni. Il nome di marca è l’asse portante dell’identità di marca. Anzi è l’asset portante dell’identità di marca, perché crea valore economico per l’impresa. Con un nome ben studiato è più facile progettare una brand identity efficace, ed è più facile costruire un’universo di marca «sexy». Con un nome banale, dal suono sgradevole, non difendibile legalmente, si riducono sensibilmente le possibilità di sviluppare un’identità vantaggiosa per l’accreditamento e il successo nel tempo del brand.
*Purtroppo, è una notizia di qualche giorno fa, il nome Yahoo! potrebbe presto scomparire per far posto ad Altaba. Sembra che Altaba sia costruito unendo le parole «alternative» e «Alibaba».